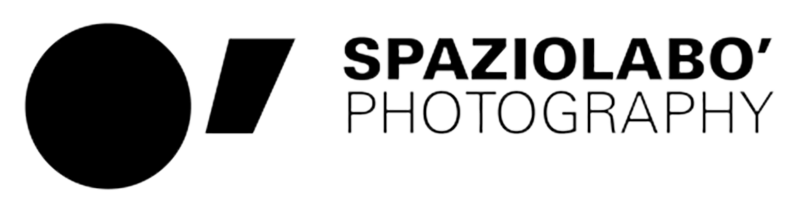ITALIANO | ENGLISH
Ugo Locatelli // Immagini lunghe
Ugo Locatelli // Immagini lunghe, 1972-2017
Proiezione/ Installazione/ Incontro con l’artista
a cura di Home Movies e Jennifer Malvezzi
Nell'ambito di Archivio Aperto
X edizione
27.10 | 02.12.2017
Spazio Labo'
Sabato 28 ottobre, ore 19.00
Ingresso libero
Le sperimentazioni filmiche d’artista realizzate a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento costituiscono un patrimonio di inestimabile valore culturale che solo recentemente sta tornando, letteralmente, alla luce. Animate dall’utopia di un nuovo cinema — l’underground, come si diceva all’epoca — quanto dalle teorie strutturaliste che si facevano strada nell’abito delle arti visive, queste operazioni recuperavano l’attenzione al dato percettivo tipica
di alcuni film delle prime avanguardie, spostando il focus sui sensi dello spettatore. Terminata quella rivoluzionaria stagione, molte di queste opere sono rimaste per decenni, come residui di un sogno infranto, confinate in un cassetto.
In un’ottica di recupero e valorizzazione della Storia, Home Movies ha recentemente curato il restauro e la ristampa di una serie di film realizzati in quel periodo dall’artista Ugo Locatelli (Bruxelles, 1940), presentati qui a Spazio Labo’ per la prima volta dopo quarantacinque anni nella loro versione originale (proiezione a parete degli originali 8mm e Super8) e introdotti dall’artista. L’idea che sta alla base delle immagini lunghe — tre brevi film costruiti a partire da tre fotografie “trovate” — è quella di esporre il pubblico a un’immagine in movimento che sarà comunque percepita come statica, cioè come immagine fotografica. Le pellicole furono proiettate per la prima volta a Piacenza nel 1972 nell’ambito della “Prima rassegna di cinema sperimentale” curata da Raffaele Perotta e dallo stesso Locatelli e in seguito vennero presentati in altri contesti nazionali e internazionali (Galerie Vautier, Nizza; Galerie Yellow Now!, Liegi). Costruito partendo dalle stesse premesse che sottendono Anémic Cinéma di Duchamp, Noi sappiamo, la prima immagine lunga qui presentata, si configura come un flickering-film nel quale il montaggio serrato tra immagine e fotogrammi neri non permette la lettura completa della scritta che appare sullo schermo, una frase che, paradossalmente, denuncia l’incertezza del riuscire ad attuare una comunicazione efficace.
Il secondo film, Tempo di lettura, è composto da una sequenza di quattro immagini ‘trovate’ volutamente ambigue. Ogni immagine si dà allo spettatore per un minuto, il tempo per interrogarsi sul suo significato. L’ultima pellicola proposta, Meta, riflette sulla convenzione visiva a causa della quale l’occhio umano ‘suppone’ che la luce provenga sempre dall’alto. Un’immagine spiraliforme in bassa definizione viene proiettata da prima in un senso e poi capovolta: lo spettatore è inconsciamente costretto a ricondurre ciò che vede a un significato formale conosciuto.
La proiezione dei film è accompagnata da un’installazione, Aree e tracce, anch’essa realizzata nel 1972, in un momento di svolta per la carriera di Locatelli che quell’anno partecipa anche alla Biennale di Venezia per poi allontanarsi volutamente dagli ambienti artistici per oltre vent’anni. Aree e tracce è una sequenza di undici immagini pensate come ambiti mentali aperti. L’opera è progettata per essere portatile e svincolata dai criteri di allestimento
usuali: le immagini possono essere viste in qualunque ambiente, proiettate a muro, oppure osservate tenendo le diapositive in mano. La proiezione delle tre Aree (area di individuazione, area d’orientamento alla pittura, area d’orientamento alla scultura) su/in uno spazio fisico permette infatti di esplicare il concetto di misurazione senza alcuna limitazione di scala o sistema e, contemporaneamente, costituisce la premessa metodologica alle Tracce, otto
immagini intese come frammenti, alcuni degli infiniti possibili della realtà visibile e come tali ‘inquadrabili’ all’interno di una cornice. Presentata per la prima volta alla Galleria Diagramma di Milano l’opera viene in seguito esposta in differenti versioni a Roma, Torino, Genova e Nizza.
Jennifer Malvezzi
Immagini Lunghe, 1972
Noi sappiamo, 8mm, 2’20’’
Tempo di lettura, 8mm, 2’50’’
Meta, Super8, 2’20’’
Aree e tracce, 1972
installazione/mostra portatile
11 diapositive 6 X 6
testo bilingue di Luciano Inga-Pin

La ricerca di Ugo Locatelli (Bruxelles, 1940) è da sempre orientata verso un’arte sistemica, all’estensione dello sguardo e del pensiero interconnessi in una rete viva di legami. Le prime opere risalgono al 1962, esperienze che analizzano la possibilità di sottrarre segni dal ‘reale’ utilizzandoli per “scrivere con la luce”. In seguito è impegnato in una serie di mostre e di operazioni tra le quali si segnalano le due edizioni di Parole sui muri, incontri internazionali di Fiumalbo (1967,1968) e il Festival Internazionale Non-Art (1969) realizzato in collaborazione con Ben Vautier. Il 1972, anno a cui appartengono i lavori qui proposti, determina una svolta nella carriera di Locatelli: espone alla Biennale di Venezia insieme allo scrittore Sebastiano Vassalli con l’opera Teatro Uno. Il Mazzo. Il gioco del teatro del Mondo, tiene una personale alla Galleria Diagramma di Milano e cura, con Raffaele Perotta la Prima rassegna di cinema sperimentale a Piacenza alla quale parteciparono, tra gli altri, anche Gianfranco Baruchello, Alberto Grifi, Ugo Mulas, Hidetochi Nagasawa, Arnaldo Pomodoro, Gianfranco Pardi e Paolo Gioli. Segue una lunga pausa, profondamente voluta, dagli ambienti artistici. Durante questo lungo periodo intensifica la riflessione e lo studio sul significato di opera d’arte e sull’interazione fra i saperi. Dal 1997 avvia il progetto Areale, un metodo di ricognizione estetica dei livelli di realtà, mai finito o finale, attuato attraverso un sentiero multidisciplinare di apprendimento per scoperta, rivolto all’ecologia dello sguardo e del pensiero.